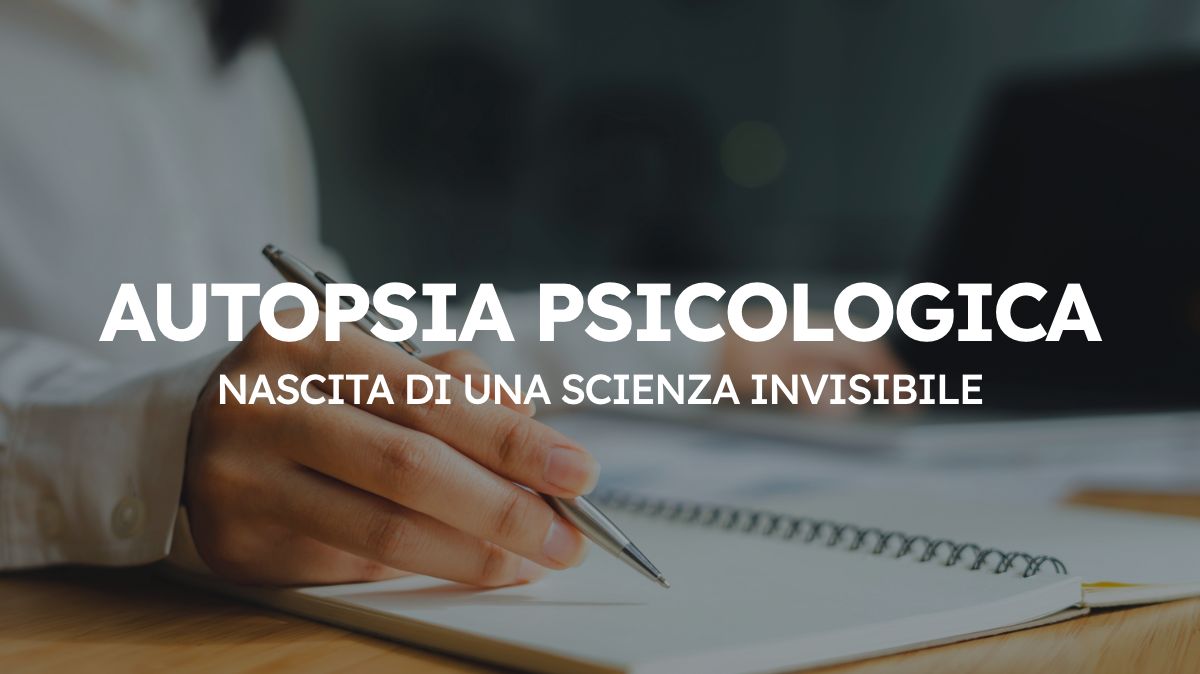In tutte le storie di scomparsa ritroviamo la sospensione della vita di chi resta, lo stato d’inquietudine, la continua oscillazione tra speranza e disperazione e, talvolta, vissuti di lutto, che si attivano ancor prima di sapere che il proprio caro sia stato ritrovato morto.
Il lutto come perdita dell’investimento affettivo
Da un punto di vista psicologico, infatti, l’esperienza dell’assenza/perdita di ciò su cui si è fortemente investito emotivamente, a prescindere dalla specifica perdita fisica (morte), è un’esperienza definibile come lutto. Umberto Galimberti, filosofo, psicoanalista italiano, definisce il lutto come uno “stato psicologico conseguente alla perdita di un oggetto significativo, che ha fatto parte integrante dell’esistenza. La perdita può essere di un oggetto esterno, come la morte di una persona, la separazione geografica, l’abbandono di un luogo, o interno, come il chiudersi di una prospettiva, la perdita della propria immagine sociale, un fallimento personale e simili” (Galimberti U., 1999, p. 617). Ciò vuol dire che in qualsiasi esperienza nella quale si vive un forte investimento emotivo, e nella quale sopravviene la perdita dell’elemento su cui si è investito, si deve disinvestire il sentimento provato, e ciò sviluppa l’esperienza del lutto. Questo è quanto accade anche per la scomparsa delle persone.
Elaborare il lutto: un percorso emotivo complesso
Il lutto è un’esperienza carica di sofferenza per coloro che perdono una persona cara: viene a generarsi una ferita, la cui cicatrizzazione richiede tempo ed energie, così da permettere, gradualmente, di ritrovare un diverso equilibrio ed un nuovo significato per la propria vita. L’elaborazione del lutto, infatti, impone alle persone un diretto contatto con le proprie emozioni e i propri ricordi, e il decorso di tale esperienza luttuosa dipende anche e soprattutto da alcuni fattori, già prima accennati, come le circostanze della morte, il tipo di relazione che si aveva con il defunto, la rete di supporto esterno a disposizione e le risorse personali su cui contare.
Quando mancano risposte: l’ostacolo del “non sapere”
Le circostanze della morte aiutano a contestualizzare il fatto, a dargli un significato – ossia la ragione della scomparsa – e sono fondamentali per l’accettazione della perdita. Per esempio, una morte improvvisa è differente da una morte causata da una malattia terminale, poiché le persone, in quest’ultimo caso, si sentono talvolta più preparate nell’affrontare tale lutto e riescono ad attribuirgli un significato; ciò è importante per rispondere alle domande: Perché questo è accaduto? In che modo? In quale luogo? Quando?
Non poter rispondere agli interrogativi di cui sopra, genera sofferenza e ostacoli cognitivi che impediscono il processo di accettazione del lutto; inoltre, non saper dare una spiegazione, non riuscire a delineare le cause della perdita, porta a processi di ruminazione che lasciano in sospeso l’elaborazione della stessa.
Il lutto congelato: una ferita aperta senza corpo
Possiamo parlare, dunque, di “sospensione del lutto” nel caso delle persone scomparse: si tratta di una dipartita improvvisa e inaspettata di qualcuno che amiamo, che porta alla genesi di una situazione di incertezza, nella quale il tempo sembra fermarsi. I parenti e gli amici di persone scomparse vivono in questo limbo con il dubbio che da un momento all’altro il loro caro possa fare ritorno, o nell’eterna speranza di almeno poterne piangere la salma o quel che ne resta.
La storia della persona scomparsa sembra, così, avvolta nell’ombra e dinanzi alla mancanza di un corpo, a chi resta viene negata la possibilità di accompagnare il proprio amico, genitore, figlio, nel suo ultimo viaggio. Il ruolo che il corpo ricopre in questo percorso di accettazione è di fondamentale importanza: il dolore prodotto dalla sua assenza si protrae in un lasso di tempo infinito che sembra non scorrere, come se qualcuno lo avesse messo in pausa e l’orologio della vita si fosse fermato in un momento preciso. La speranza di ritrovare chi ora non c’è affievolisce, talvolta, quella sofferenza, ma tale ciclicità provoca un enorme stress e una grande angoscia che non sembra avere rimedio.
L’importanza del corpo nel rituale della perdita
Metabolizzare la perdita di una persona cara è un percorso fortemente doloroso, che attraversa varie fasi e necessita di essere vissuto da colui il quale sta affrontando il lutto, senza fretta e coscientemente, affinché questi possa, prima o poi, arrivare alla completa accettazione di una nuova realtà, in cui il proprio caro non esiste più. Durante questo cammino è indicato spogliarsi di sentimenti quali rabbia, senso di colpa e frustrazione, che seguono sovente la perdita di un amico, di un amato o di un familiare. Tuttavia, il privilegio di poter intraprendere questa strada verso la cura della propria anima non è concesso a tutti.
Come afferma Gorer, nel 1973, “in tutte le culture vi è la constatazione di regole che disciplinano il trattamento della salma e il comportamento dei parenti del defunto. Tali regolamenti sono presenti assieme ad altri aspetti fondamentali per il genere umano”; questa osservazione convalida l’enorme importanza del rito funebre per favorire la continuità della vita all’interno delle società conosciute: è per coloro che restano che, in realtà, viene celebrato il rituale.
Per comprendere al meglio il valore del corpo e, conseguentemente, della tomba di un proprio caro estinto, si riporta un celebre carme foscoliano, ‘Dei Sepolcri’, pubblicato a Brescia nel 1807.
“Deorum manium iura sancta sunto”
Foscolo ribadisce, all’inizio di questo poemetto, come prima di lui aveva fatto Cicerone, che i diritti degli Dèi Mani, divinità dell’oltretomba, sono sacri e inviolabili. Questo in risposta alla legislazione napoleonica che, nel 1806, aveva esteso in Italia l’Editto di Saint-Cloud. L’ordinanza imponeva che i cimiteri fossero posti al di fuori delle mura cittadine e che le lapidi fossero composte solo dal nome del defunto, impedendo la costruzione di mausolei.
L’autore si sofferma sull’utilità dei sepolcri nei primi novanta versi e, nello specifico, al trentesimo endecasillabo afferma che in un mondo in continuo divenire solo il sentimento, la corrispondenza d’amorosi sensi, sia capace di garantire all’uomo l’immortalità, e lenire, come un balsamo, gli animi dei cari del defunto. Per Foscolo tale corrispondenza è celeste, divina, perché grazie ad essa, spesso, noi continuiamo a vivere con l’amico defunto ed egli con noi, a patto che si rendano inviolabili le sue reliquie e una pietra ne conservi il nome.
I familiari delle persone scomparse non hanno una vera lapide, né una vera inscrizione, attraverso cui poter dare inizio a questa sentimentale e salvifica corrispondenza; in questi non vi è alcuna rassegnazione, solo una speranza corrosiva che, tuttavia, non placa le sofferenze ma che, anzi, le acuisce.
L’effetto della scomparsa sul tempo psichico
Pertanto, nel caso delle persone scomparse, di cui non viene più trovato neanche il corpo, il processo del lutto rimane spesso bloccato, sospeso, comunque differito, sempre rimandato, diventando assolutamente difficile pervenire ad una piena accettazione della perdita dell’Altro. La prima sensazione che i survivors provano è che il tempo sembri indeterminato e confuso: si muovono in un presente che si mostra eterno ed il futuro viene continuamente procrastinato, per cui diventa difficile, se non impossibile, organizzare la propria vita, progettare, programmare, evolvere, vivere.
Tempo, psiche e blocco evolutivo
La realtà del tempo può essere riconosciuta come una struttura portante di ogni organizzazione psichica (Bortolo e Bertrando, 1993). Insieme allo spazio, è dentro il tempo che ci muoviamo ed organizziamo la nostra esistenza. Non a caso, infatti, uno dei primi sintomi di disagio psicologico è il disorientamento nel tempo e nello spazio (Sbattella, 2016). Si può ben comprendere, dunque, come, saltando l’asse del tempo, in una oscillazione perpetua che va tra due polarità, quali la speranza e la disperazione, nella vita di chi sopravvive alla scomparsa improvvisamente si blocca la possibilità di far evolvere ogni dinamica psichica, relazionale, sociale. Condizione, questa, che ben giustifica la fatica di vivere descritta da chi è coinvolto in queste tragedie.